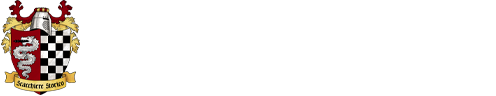di Marco Giuseppe Longoni
Il Signor Cardinal Bentivoglio hà scritte in nostra lingua alcune operette historiali con tanta eminenza, che né per lo stile, né per la prudenza io saprei desiderar di vantaggio. La dicitura è sempre nobile, e numerosa; i concetti concatenati, e proprii; le considerationi piene d’avvedimento; le sentenze opportune, e gravissime; le concioni eloquenti, et efficaci. Insomma veggo in ogni lor parte una maravigliosa mistura d’eleganza, e di giudicio (Mascardi, 1639).
Queste le parole che Agostino Mascardi (1590-1640), perspicace teorico della storiografia seicentesca, dedicava ad uno dei più importanti storici del suo tempo e suo grande amico: il cardinale Guido Bentivoglio. Un giudizio confermato perfino da Benedetto Croce, che lo riteneva uno degli ultimi interpreti della storiografia rinascimentale nella presunta decadenza dell’Italia post-tridentina (Croce, 1993).
- La vita di Guido Bentivoglio
Guido Bentivoglio (1577-1644) nacque in seno all’illustre famiglia che aveva governato Bologna per tutto il XV secolo. Il padre Cornelio, nipote dell’ultimo signore Annibale, aveva servito in Francia e in Scozia e s’era distinto nella Guerra di Siena al fianco di Piero Strozzi e Blaise de Monluc, ottenendo da Enrico II il feudo di Vigone e l’investitura a cavaliere dell’Ordine di San Michele; al seguito di Alfonso II d’Este in Ungheria, fu ricompensato con il titolo di marchese di Castel Gualtieri. La madre era Isabella Bendidio, donna coltissima e sorella di Lucrezia, amata da Torquato Tasso.

A diciassette anni, Guido Bentivoglio si iscrisse all’Università di Padova, vestì l’abito ecclesiastico e prese lezioni da Antonio Riccoboni, autore di un interessante trattato sullo statuto della storia, da Carlo Salice e Galileo Galilei. Si accostò nello stesso tempo anche agli studi storici:
Fin d’allhora io godeva con sommo piacere di trovarmi à quelle tante, e sì varie Scene di casi humani, che dall’historia si rappresentano. Dall’historia, dico, la quale unendo le memorie sepolte con le più vive; & i secoli più lontani co’ più vicini, à guisa di Scola publica in mille efficaci modi ammaestra i Prencipi, ammaestra i Privati, e fà specialmente conoscere quanto uguale, e giusta con tutti sia l’alta mano di Dio; e quanto più frà le miserie, che frà le felicità ondeggi l’huomo in questo sì naufragante commune Egeo della vita mortale» (Bentivoglio, 1648).
Guido Bentivoglio dimostrò ottime abilità diplomatiche, quando, in occasione della devoluzione di Ferrara (1598), riuscì a preservare l’onore e le sostanze della famiglia chiedendo perdono al cardinale Pietro Aldobrandini del sostegno che suo fratello Ippolito aveva accordato a Cesare d’Este. Incoraggiato dalle promesse di papa Clemente VIII, si laureò in utroque iure e si recò a Roma.
Iniziò fin da subito a prendere lezioni di geografia (disciplina alla quale sarebbe rimasto profondamente legato) da Traiano Boccalini, «versatissimo in quella sorte di studij, e che insieme era gran Politico, mà in particolare grande Anotomista, e minuzzatore di Tacito» (Bentivoglio, 1648). Grazie alla nomina a cameriere segreto del pontefice, Bentivoglio fu assiduo habitué dei cardinali Cesare Baronio, Roberto Bellarmino e Silvio Antoniano. Tra le frequentazioni quotidiane c’era anche il padre gesuita Giovanni Pietro Maffei (1536-1603), autore di una vita di Ignazio di Loyola e di una celebre storia delle Indie, impegnato nei primi anni del secolo nella composizione degli Annali di Gregorio XIII: «Veniva egli spesso alle mie stanze, & io spesso andava alle sue con la mia carrozza insieme con altri amici. […] Mostrava egli à me le compositioni sue da maestro, & io à lui le mie da scolaro. Godevo de suoi documenti; gli osservavo come tante lettioni, e gli riverivo, come se quei famosi latini del secolo d’Augusto con le proprie loro bocche me gli havessero proferiti» (Bentivoglio, 1648).
Furono anni decisivi per la formazione di Guido Bentivoglio. La vicinanza al pontefice e alle gerarchie ecclesiastiche gli garantirono una posizione privilegiata dalla quale assistere alle trattative che portarono alla firma del trattato di Lione (1601), che sancì il passaggio del marchesato di Saluzzo al ducato sabaudo. Mediatore tra le parti fu il cardinale Pietro Aldobrandini, che scongiurò lo scoppio di un conflitto tra la Francia e gli Asburgo, favorevoli alle rivendicazioni di Carlo Emanuele.
Nel 1607 Guido Bentivoglio fu consacrato arcivescovo e designato da papa Paolo V Borghese alla nunziatura in Fiandra, la cui giurisdizione si estendeva anche all’arcipelago britannico, alla Danimarca e alla Norvegia. L’attività del nunzio fu dedicata ad appoggiare i principi Alberto e Isabella nelle trattative di pace tra la Spagna e le Province Unite, che sfociarono nella Tregua dei dodici anni (1609-1621), foriera dell’incredibile espansione economica olandese nelle Indie orientali.
Appena sopiti i clamori delle armi, Bentivoglio dovette fronteggiare lo scoppio della guerra di successione al ducato di Jülick-Kleve (1609-1614), combattuta tra il cattolico conte palatino di Neuburg, appoggiato dagli Asburgo, e il principe elettore di Brandeburgo, calvinista e sostenuto dall’Inghilterra, dalla Francia e dalle Province Unite. Il momento di massima crisi si verificò nel novembre 1609, quando il principe Enrico II di Borbone-Condé scappò dalla Francia per Bruxelles – ufficialmente per difendere l’onore della moglie insidiata dagli appetiti sessuali del sovrano – ponendosi sotto la protezione della Spagna e del pontefice, il che infiammò l’animo guerresco di Enrico IV. Con non poco imbarazzo, Bentivoglio cercò di conservare la pace: «io haveva passati prima quegli offitij di concordia, e di pace, ch’erano stati da me giudicati più a proposito in così fatta occorrenza, e che poi rinovai più volte per ordini particolari, che me ne diede il Pontefice» (Bentivoglio, 1630). Dinanzi alla fermezza della corte spagnola, Enrico IV si schierò apertamente con l’elettore di Brandeburgo e mobilitò le proprie forze per invadere i Paesi Bassi spagnoli, la Germania e l’Italia, con la segreta intenzione di attrarre a sé Venezia e il Papato. Solo l’improvviso assassinio del re per mano del fanatico François Ravaillac pose brutalmente fine ai preparativi di una nuova guerra europea.
Negli anni della nunziatura, Bentivoglio non trascurò, per altro, di occuparsi della rifioritura della fede cattolica nelle Fiandre, appoggiandosi alle università di Douai e di Lovanio, all’adozione del catechismo scritto dal gesuita Lodewijk Makeblyde e alla fondazione delle scuole domenicali.
Nel 1616 partì per Parigi con la nomina alla nunziatura di Francia. La situazione era ben diversa da quella che aveva lasciato nelle Fiandre, come scrisse al conte Annibale Manfredi: «Quì, benchè mi ci havessi a fermar nove secoli, un giorno di Corte mai non sarà simile all’altro» (Bentivoglio, 1680).
Questa estrema mutevolezza nasceva dalle tensioni createsi in seno alla monarchia negli anni in cui Maria de’ Medici (1575-1642) esercitò, come è noto, la reggenza per il figlio Luigi. La politica estera filospagnola della regina, se da un lato aveva recuperato la fedeltà dei Guisa, dall’altro aveva incitato, unita alla prodiga generosità accordata a Concino Concini, maresciallo d’Ancre, i Condé e i Vendôme a sollevare nel 1614 l’Est e la Bretagna reclamando un maggiore peso nei confronti della Corona attraverso la convocazione degli Stati Generali. Repressa rapidamente la rivolta principesca, gli Stati Generali era stati riuniti ugualmente e, attraverso un’accurata selezione dei rappresentanti dei tre ordini, si erano conclusi con un nulla di fatto (solo il Parlamento di Parigi aveva criticato aspramente la gestione delle finanze e il favore accordato al seguito italiano della reggente) (Le Roy Ladurie, 2000). Al suo arrivo, il nunzio, dissimulando la propria ostilità verso l’arroganza del favorito, cercò di favorire una pacifica composizione tra la regina, il figlio Luigi e i malcontents (famiglie principesche e Ugonotti). In un clima di inesorabile guerra civile, con Concini che si apprestava a colpire militarmente gli oppositori, l’11 aprile 1617 Bentivoglio scrisse a Scipione Borghese che «Ancre vuol ad ogni modo la guerra, e vorrebbe veder rovinati questi Principi, e poi Guisa e gli altri, per regnar solo; onde bisogna che succeda qualche gran cosa, e presto; ed io n’ho riscontri grandissimi e sicurissimi» (De Stefani, 1863; Belvederi, 1962; Tabacchi, 2012). Tredici giorni dopo, Concini cadeva ammazzato durante il coup de force di Luigi XIII. Il sovrano aveva giocato d’astuzia, ma, di fatto, aveva introdotto un nuovo favorito: Charles d’Albert de Luynes.
Il nunzio cercò nei due anni successivi di favorire la riconciliazione tra Luigi XIII e la madre per scongiurare la rivolta dei principi e degli Ugonotti. In un clima di rinnovata guerra civile, Guido Bentivoglio constatava con amarezza che «questa Corona è come un’abbadia vacante, per così dire: Luynes, che la gode, vuol tuttavia restarne in possesso; la Regina madre la vuole; Condé la vuole; Soissons la vuole; il Consiglio la vuole; i principi la vogliono; i Parlamenti la vogliono; e è certo che, se il Re non si sveglia, ognuno di questi potria pigliarsene un pezzo» (De Stefani, 1870). La situazione degenerò durante l’estate: il 7 agosto Luigi XIII sconfisse l’esercito della madre a Les Ponts-de-Cé, sulla Loira.
La ritrovata pace che ne seguì fu interpretata come l’occasione propizia per distruggere il principale nemico degli interessi romani in Francia: gli Ugonotti. Tempo prima, Roma aveva messo a segno un colpo decisivo, quando Luigi XIII aveva decretato nel 1617 l’unione del Béarn e della Navarra alla Corona francese, dunque la restituzione dei beni confiscati al clero cattolico durante il regno di Jeanne d’Albret (1555-1572), suscitando la fiera opposizione dei riformati. Nella Breve Relatione degli Ugonotti del 1619, Bentivoglio aveva scritto che «si può giudicare, che finalmente sia per cadere estinta, com’hò detto, quest’Hidra d’impietà, e di ribellione; e che il Rè presente, con voci di sommo applauso al suo nome, e con hinni di gloria immortale a Dio, sia per essere il debellatore di questo mostro» (Bentivoglio, 1630). Il più acceso paladino della guerra era Enrico di Condé, che in gran segreto assicurò il nunzio di un’imminente campagna contro La Rochelle, il quale tuttavia non si ingannava sulle vere intenzioni del principe, interessato a ricoprirsi di gloria militare. Gli Ugonotti si sarebbero piegati solo nel 1628 dinanzi all’imperiosa offensiva scatenata da Richelieu.

Oltre ai delicati rapporti in seno alla famiglia reale e alla nobiltà, Bentivoglio si misurò anche con i grandi eventi della propria epoca, con l’obiettivo dichiarato di preservare la libertà d’Italia. Nel 1617 aveva dato buona prova delle proprie capacità impedendo che la Francia si schierasse con i Savoia contro la Spagna (Prima guerra del Monferrato) e con Venezia contro gli Asburgo d’Austria (Guerra di Gradisca). La conflagrazione del conflitto europeo nel 1618 e l’incerta posizione francese posero Bentivoglio in una posizione molto delicata: Scipione Borghese chiese sempre più frequentemente novità degli umori della corte per gli affari di Germania e d’Italia, mandando dettagliati resoconti di eventi particolarmente rilevanti come la rivolta in Valtellina 1620 (Belvederi, 1962).
Agli inizi del 1621, Bentivoglio fu richiamato in Italia con l’elevazione al cardinalato, alla quale fece seguito la decisione di Luigi XIII di designarlo protettore di Francia presso la Santa Sede. Negli anni seguenti ottenne incarichi nella Curia romana e la nomina a inquisitore generale. Il 22 giugno 1633 il cardinale Bentivoglio, nonostante avesse cercato di aiutarlo con qualche cautela, fu tra dieci ecclesiastici che pronunciarono la sentenza di eresia contro Galileo Galilei, il suo vecchio maestro, «e Dio sà quanto mi dolse di vederlo riuscire un Archimede così infelice per colpa di lui medesimo in haver voluto publicare sù le stampe le sue nuove opinioni, intorno al moto della Terra contra il vero senso commune della Chiesa» (Bentivoglio, 1648). Alla morte di Urbano VIII nel 1644, Bentivoglio era tra i papabili appoggiati dalla Francia, ma morì durante il conclave dal quale sarebbe uscito Innocenzo X.
Negli anni del cardinalato Bentivoglio si occupò della revisione e della diffusione delle sue opere storiografiche. Nel 1629 furono stampate ad Anversa dall’umanista Eric de Put le Relazioni del cardinale Bentivoglio, dedicati alle vicende storiche, politiche e religiose nelle Province Unite, nelle Fiandre, in Inghilterra, Scozia e Irlanda e al trattato di Anversa; a questi resoconti si affiancavano quattro brevi relazioni sulla Danimarca, sugli Ugonotti, sulla fuga di Condé del 1609 e sulla successione al ducato di Jülich-Kleve. Due anni dopo furono date alle stampe le Lettere degli anni delle nunziature. Nel 1632-1639 uscì a Colonia l’opera principale: Della guerra di Fiandra, nella quale l’autore descrisse gli avvenimenti che avevano scatenato la rivolta dei Paesi Bassi e alimentato il conflitto contro la Spagna, abbracciando il periodo tra il 1559 e il 1609. Poco prima della morte, Bentivoglio compose le proprie Memorie, che uscirono postume nel 1647 a Venezia e ad Amsterdam.
Sarebbe riduttivo esaurire una biografia di Guido Bentivoglio senza fare un cenno al suo grande amore per l’arte, le humanae litterae e la musica. Risalente agli anni ferraresi era il rapporto con il clavicembalista e compositore Girolamo Frescobaldi (1583-1643), che accompagnò Bentivoglio nelle Fiandre, dedicandogli nel 1608 il Primo libro de’ madrigali a cinque voci:
Son venuto in Anversa con licenza di Vostra Signoria Illustrissima per vedere questa Città, e per metter in prova una muta di Madrigali ch’io sono andato componendo costì in Brusselles, in casa di Vostra Signoria Illustrissima da che mi trovo in Fiandra. […] Uscirà donque in luce questa mia prima fatica […] come conveniva sotto ’l nome di Vostra Signoria Illustrissima. La quale con infinita benignità s’è degnata di favorirmi sempre nell’essercitio del talento, ch’à Dio benedetto è piaciuto darmi (Frescobaldi, 1608)
Nel 1619 Bentivoglio acquistò il palazzo sul Quirinale (oggi Palazzo Pallavicini Rospigliosi) fatto costruire da Scipione Borghese sui ruderi delle Terme di Costantino, vicino alla residenza pontificia, e lo dotò di una notevole collezione di dipinti. Al 1623 risale il ritratto realizzato da Antoon van Dyck, il quale, scrisse Giovanni Pietro Bellori, «fù trattenuto in Corte del Cardinale Bentivogli amorevole della natione, fiamminga, per essere egli dimorato in Fiandra, e per havere scritto quella historia, che vive immortale. Espresse Antonio il Cardinale à sedere con una lettera nelle mani, e quasi l’habbi letta, si volge, e portò su la tela la similitudine del volto, e lo spirito moderato di quel Signore» (Bellori, 1672). Dal 1627 Bentivoglio iniziò a frequentare l’artista Claude Gellée detto Le Lorrain (1600-1682), diventando suo protettore e mecenate: «Per ordine del Cardinale Bentivogli ebbe a fare due paesi che gli guadagnarono tanto credito, non solo appresso a quel gran Prelato, ma eziandio alla Santità del Pontefice Urbano VIII» (Baldinucci, 1728; Haskell, 2020). In Francia il cardinale aveva stretto forti rapporti anche con Giovan Battista Marino (1569-1625), il massimo esponente della poesia barocca italiana. Il 7 aprile 1620 Bentivoglio scrisse a Marino una calorosa lettera per informarlo di avere terminato la lettura gli idilli della Sampogna e per esortarlo a dare alle stampe altri nuovi poemi. Soprattutto, ammoniva «il mio Cavaliere, di gratia (come tante volte v’hò detto) di purgar l’Adone dalle lascivie in maniera, ch’egli non habbia da temere la sferza delle nostre censure d’Italia, e da morir più infelicemente al fine la seconda volta con queste ferite, che non fece la prima con quelle altre, che favolosamente da voi saranno cantate» (Bentivoglio, 1680), con la paterna raccomandazione a non curarsi dei detrattori. Nel 1623, superando i ripensamenti, Marino diede alle stampe la prima edizione de L’Adone, consacrata alla maestà di Luigi XIII (Marino, 2018).
- Una galleria di ritratti esemplari
Non è certo possibile riassumere ed esaurire la straordinaria ricchezza tramandata dalle opere di Guido Bentivoglio. Cercherò di delineare i caratteri essenziali del suo pensiero storiografico.
In primo luogo, in linea con la tradizione ciceroniana, la storia è per il cardinale Bentivoglio magistra vitae e deve necessariamente parlare di grandi gesta: «Havendo per oggetto l’insegnare, & il dilettare, mà in primo luogo il produrre con l’insegnamento la prudenza militare, e civile: non può conseguire un tale fine col mezzo de’ racconti bassi, minuti, e leggieri, e tanto alieni dal suo così grave, e maestoso instituto» (Bentivoglio, 1648). Oltre a Cicerone, Raffaele Belvederi ha individuato anche un’eredità lasciata dalla scuola ferrarese di Guarino da Verona, che aveva fondato un ordine di studi in cui le letture storiche rivestivano un ruolo formativo (civile, morale e politico) cruciale per i fanciulli. Come scrisse Battista Guarini, che successe al padre alla guida della scuola, nel De ordine docendi ac studendi: «Gli si offriranno in lettura Valerio e Giustino con i quali si potrà abbracciare, quasi in un’unica visione, la storia romana e quella dei popoli stranieri. […] In seguito leggeranno in successione gli altri storici e da una parte apprenderanno i costumi, le istituzioni, le leggi di diversi popoli, dall’altra le varie vicende degli uomini, i vizi e le virtù degli animi» (Guarini, 2002; Belvederi, 1962; Garin, 1976).
Negli scritti di Bentivoglio, questa posizione emerge dai ritratti esemplari dei personaggi celebri (sovrani, ecclesiastici, militari e governanti), modellati sulla storiografia classica e arricchiti con concetti propriamente rinascimentali, come il ruolo della fortuna nelle vicende umane. Il cardinale seguiva la lezione di Francesco Guicciardini, che nell’incipit della Storia d’Italia aveva scritto: «Per innumerabili esempli evidentemente apparirà a quanta instabilità, né altrimenti che uno mare concitato da’ venti, siano sottoposte le cose umane» (Guicciardini, 2006).
Il caso emblematico è il ritratto di Filippo II di Spagna. Dal portamento grave e maestoso, il sovrano è descritto in Della guerra di Fiandra come un esempio di pietà e di giustizia, zelante difensore della Chiesa cattolica, instancabile promotore della pace, prudente in politica domestica ed estera, sempre attento a circondarsi di ministri meritevoli, più che di favoriti. Le sue ottime virtù e le vittorie ottenute in Francia, in Portogallo e a Lepanto lo elevarono sopra tutti i sovrani d’Europa, ma gli «aggiramenti varii della fortuna», ovvero la rivolta delle Fiandre, la sconfitta della Invencible Armada, le bancarotte, le morti premature delle mogli e la drammatica fine del figlio don Carlos si abbatterono come una folgore sugli ultimi anni del suo regno. «Ma ne’ casi della fortuna, come per la maggior parte furono questi, non si può colpar la prudenza humana. Che nel resto le virtù proprie di Filippo Secondo apparirono in grado sì alto, e lo resero Prencipe così memorabile, che pochi altri a lui simili senza dubbio, e frà i più remoti tempi, e frà i più vicini, malagevolmente si troveranno» (Bentivoglio, 1639).

Un altro protagonista di rilievo della politica europea è Enrico IV di Francia: «Rè de’ maggiori, e più memorabili, che mai havesse havuti quel Regno. […] Le sue lodi risonavano maravigliosamente per ogni parte dell’universo; e correva una general costante opinione, che da gran tempo non si fosse veduto Rè di più chiara fama». A differenza di Filippo II, tuttavia, il sovrano francese, giudicato smodatamente avvezzo agli amori e ai piaceri, viene dipinto come autore delle proprie disgrazie, poiché, invaghitosi della duchessa di Condè, spinse il marito a schierarsi tra i suoi più ferventi oppositori e a stringere pericolose alleanze con Madrid. Anche re Enrico, tuttavia, soccombe ai cruenti colpi della fortuna inferti dal pugnale di Ravaillac: «Onde imparino di quà i Prencipi, e frà loro i più poderosi, a conoscere le miserie, che vanno miste con le loro felicità; e quanto spesso nel theatro dell’humane tragedie essi faccian le scene più funeste, e più lamentabili» (Bentivoglio, 1630).
Estrema attenzione viene posta anche a grandi militari come Alessandro Farnese, «Gran Capitano invero! E di nome sì chiaro senz’alcun dubbio, che la sua fama può collocarlo trà i più celebri dell’antichità» (Bentivoglio, 1636), Maurizio di Nassau e Ambrogio Spinola
e veramente, contrapesato il proceder militare dell’uno, e dell’altro, si direbbe, che Mauritio fosse uscito dalla Scuola di Fabio, e lo Spinola da quella di Cesare; l’uno havendo sfuggito quasi sempre, e l’altro quasi sempre cercato il combattere; l’uno mostrandosi Cuntatore non solo per natura, ma per elettion di vantaggio; e l’altro tutto intento con l’ardire, e con la celerità a far vantaggiosi i successi della sua parte (Bentivoglio, 1633).
Nella grande arena delle Fiandre, non mancano, in aggiunta, esempi da rifuggire, come quelli di don Giovanni d’Austria, eccessivamente incline alla lussuria e ambizioso, di Francesco di Valois, duca d’Alençon, troppo arrendevole verso favoriti senza scrupoli, di Luigi di Nassau e di Filippo di Montmorency, ambedue di nature feroci e temerarie. Tutti uomini eroici nella grandezza delle loro virtù e dei loro vizi, tutti impotenti di fronte agli «aggiramenti varii della fortuna». Così don Giovanni d’Austria, nato per «esercitare i comandi più in termine d’assoluto Prencipe, che in qualità di subordinato Ministro» (Bentivoglio, 1678); così Francesco di Valois, «terminò il vivere quando in lui con l’età fiorivano più le speranze; perch’egli […] non solamente si prometteva di goder tuttavia il Prencipato di Fiandra, ma con più alta fortuna di succedere al proprio Regno ancora di Francia» (Bentivoglio, 1636). Giudizi che riecheggiano la fine, descritta da Guicciardini, di Luigi XII, morto «in tempo che pareva gli ritornasse la prosperità della fortuna, avendo difeso il regno suo, fatta la pace e parentado e in grandissima unione col re d’Inghilterra» (Guicciardini, 2006). Pure intorno a Fernando Álvarez de Toledo, duca d’Alba, dopo averne elogiato le capacità militari paragonandolo al Temporeggiatore, Bentivoglio non risparmia critiche, giudicandolo severo oltre misura e colpevole di ubris per aver fatto collocare ad Anversa una statua che lo ritraeva nelle vesti di trionfatore dei Fiamminghi: «Come se in quella statua il Toledo havesse voluto farsi veder publicamente sù i loro colli; e come se non contento d’havergli ridotti hormai in total servitù, volesse ancora ostentarne in forma a loro sì ignominiosa i trofei» (Bentivoglio, 1633).
Un discorso a parte merita il grande protagonista della Guerra di Fiandra, il principe Guglielmo d’Orange (1533-1584). Lo storico gli riconosce l’abilità oratoria, l’intelligenza, le maniere cavalleresche e la prudenza, biasimandolo, tuttavia, senza mezzi termini per la sua ambizione e per aver piegato la propria fede agli interessi politici. Come ha rilevato Alberto Clerici, l’ammirazione che il cardinale nutriva per il principe, e più in generale per i ribelli olandesi, non deve indurre a collocarlo in un preciso schieramento favorevole od ostile alla politica spagnola; semmai, Bentivoglio si pone sempre in una posizione critica nei confronti degli eventi e, soprattutto, dei personaggi, sempre attento a coglierne le vere intenzioni celate dietro alle maschere (Clerici, 2009). Il ritratto del principe d’Orange e le sue orazioni richiamano direttamente le figure dei grandi ribelli che cercarono di opporsi a Roma, come il caledone Calgaco e, nel nostro caso, Gaio Giulio Civile, capo della rivolta batava del 69-70 d.C. narrata da Tacito nelle Historiae, come Bentivoglio stesso affermava nella Relatione sulle Provincie Unite. Una reminiscenza divenuta quasi “mito fondativo”, come si può ben osservare dalla Congiura di Giulio Civile commissionata nel 1660 a Rembrandt dal Municipio di Amsterdam. Degna di nota per le somiglianze con quelle del nobile batavo è l’orazione pronunciata da Guglielmo d’Orange nel 1568 dinanzi all’assemblea dei principi e delle città tedesche favorevoli alla rivolta fiamminga contro la Spagna. È un capolavoro di retorica:

Io fabricator di congiure; io capo di seditioni; io peste di quei paesi, son tenuto, e chiamato; contro di me tuona l’ira maggiore; & in me sono cadute di già le più atroci pene. Così cercano di convertire la mia gloria in infamia. E qual gloria maggiore, che sostener la libertà della patria, e voler più tosto morir, che servire? […] Ma quanto grande apparisce, quanto smoderata questa avidità spetialmente negli Spagnuoli? Per satollarla stimano poco essi i lor Mondi incogniti, e perciò voglion distender l’Imperio loro sempre maggiormente ne’ conosciuti. All’Europa dirizzano gli occhi in particolare, e molto più le machinationi. […] Chi vuol gettar bene i fondamenti della servitù, cerca d’abbatter prima i propugnacoli della libertà. […] E quella virtù, ch’in essi [nei ribelli fiamminghi], per sì inaspettata, e sì fiera violenza, è più tosto instupidita, che oppressa, tornerà più vigorosamente, che mai a risorgere. E che non può la disperatione armata? Che non ardisce? […] Quante volte si vede tornar l’oppressione in rovina dell’oppressore? Così potrebbe parimente succedere, che volendo gli Spagnuoli occupare con tanta ingordigia gli Stati d’altri, venissero a perdere finalmente i lor proprii. […] La causa non può esser più giusta; né l’aiutarla più facile. È vostra non meno, che nostra.
Con una chiusura magistrale, degna di Annibale Barca: «Non hebbe mai la Corona di Spagna, e mai non havrà nemico più acerbo del Prencipe d’Oranges» (Bentivoglio, 1633). Non si dimentichi, tuttavia, che Tacito aveva fornito un giudizio negativo su Giulio Civile: «sic in Gallias Germaniasque intentus, si destinata provenissent, validissimarum ditissimarumque nationum regno imminebat» (Tacito, 2009). Lo stesso formulato da Bentivoglio riguardo al principe d’Orange «Restava nondimeno egli nella condition di vassallo; e dall’altra parte erano sì alti i suoi spiriti, che non potevano lasciarlo quieto se non in quella di Prencipe. Aspirò egli dunque a’ potere inalzarvisi, come s’è veduto, frà le rivolte di Fiandra» (Bentivoglio, 1636).
- Oltre le maschere: un teatro di negotii
Un secondo aspetto emblematico del pensiero di Bentivoglio è la necessità di descrivere, oltre alle vicende militari, i negotii, cioè le trattative diplomatiche e gli interventi pronunciati ad assemblee e consigli di particolare rilevanza. È lo stesso autore ad avanzare tale proposta nelle sue Memorie, giudicando il De bello belgico di Famiano Strada manchevole sotto questo aspetto:
Con l’armi particolarmente vanno sempre uniti i Consigli, poiché non suole pigliarsi alcuna grave risolutione ò militare, ò civile, che nelle Consulte di Stato, ò di guerra non si esami bene prima, e non si maturi. Dunque à penetrare i Consigli, & ogni altro successo in materia di negotio, che pesi, & à renderne quanto più sia possibile ben’informati i lettori; deve l’historico applicare la sua maggiore attentione. Questa parte, che in apparenza non è la più strepitosa, e nondimeno in effetto la più importante (Bentivoglio, 1648).
Nella seconda sezione delle Memorie, Bentivoglio ha tentato di scrivere una storia conforme a queste finalità, descrivendo le cause, le vicende e le trattative della guerra franco-savoiarda per il controllo di Saluzzo, i cui protagonisti indiscussi furono re Enrico IV, il duca Carlo Emanuele I, il plenipotenziario pontificio Pietro Aldobrandini e Pedro Énriquez de Acevedo, conte di Fuentes e all’epoca governatore di Milano.

La passione per i negotii emerge, per ovvi motivi, soprattutto dalle lettere e dalle relazioni delle nunziature, prodotte per il cardinale Scipione Caffarelli-Borghese, segretario di Stato, non solo come resoconti storici, ma anche, e soprattutto, come strumenti necessari al funzionamento della politica estera del papato paolino (1605-1621) in precise circostanze politiche d’importanza europea, quali la Tregua del 1609, la successione al ducato di Jülick-Kleve e le delicate fasi della reggenza di Maria de’ Medici. Questa sensibilità è ben presente anche in Della guerra di Fiandra, soprattutto nella descrizione di alcuni momenti cruciali come la stipula dell’Atto di abiura del 1581, frutto di intensi dibattiti interni (tra Cattolici e Riformati) e di intromissioni esterne (francesi e inglesi), con cui i Paesi Bassi dichiararono la deposizione di Filippo II e la nomina di un nuovo sovrano nel duca d’Alençon.
L’attenzione ai meccanismi della politica si accompagnava, inoltre, a compiti più spirituali quali la strenua difesa dell’ortodossia tridentina e la protezione delle comunità cattoliche in terra riformata, senza dimenticare la tutela della sovranità su Avignone e delle prerogative della Chiesa romana e, non ultima, la persecuzione degli Ugonotti in Francia. Sotto questo punto di vista sono indicativi i capitoli della Relatione di Fiandra dedicati alla situazione religiosa in Inghilterra, Scozia e Irlanda, esaurientemente approfonditi da Raffaele Belvederi, nei quali emerge la consapevolezza che Giacomo I non sarebbe stato il tanto atteso restauratore del Cattolicesimo in Inghilterra, nonostante fosse il figlio di Maria Stuart, «divenuta più gloriosa per la Corona acquistata di Martire, che per quella, che portò di Regina» (Bentivoglio, 1630). Da questa visione disincantata discendeva la necessità da parte del nunzio Bentivoglio di attuare un’intesa con l’arciduca Alberto e la moglie Isabella per appoggiare, unire e accrescere i cattolici inglesi, sovente colpiti dalle lotte tra la Corona e il Parlamento. Nelle intenzioni dell’autore, la protezione doveva essere estesa soprattutto al clero inglese (non tanto alla Compagnia di Gesù), da formare nei seminari fiamminghi, e ai conti di Tyrone e Tyrconnel, accolti nel 1608 da Paolo V, senza però assecondarne le proposte insurrezionali (Belvederi, 1962).
- La storia per leggere il presente
L’attività storiografica di Guido Bentivoglio non è estranea all’approfondita e pesata interpretazione del presente. Un esempio paradigmatico è la tesi «Se questa nuova Republica delle Provincie Unite sarà durabile», posta in termini problematici intorno al concetto di amore per la libertà e alla carica dello Statolderato, ovvero al ruolo istituzionale dei principi d’Orange nella politica olandese. L’autore considera l’amor di patria come un patrimonio naturale degli Olandesi, che si vantavano di discendere dagli antichi batavi che si erano ribellati a Roma, e la forma di governo (autonomia alle province e alle città, con il principe-statolder come istituzione sovrana) un eccellente esempio di concordia e di potenza. D’altro canto, tuttavia, sempre valida risultava la lezione di Tacito (dietro al cui nome si celava spesso e volentieri Machiavelli) che «quanto all’amor della libertà, vedesi, ch’in suo luogo è succeduto il comodo dell’ubbidienza ne’ popoli; i quali di tempo in tempo si sono poi sottomessi quasi per ogni parte del mondo all’impero d’un solo. Furono veramente tutti i Rè da principio, Capi, e non Rè; di Republiche, e non di Regni» (Bentivoglio, 1630). Vale a dire che lo statolder, soprattutto se dotato, come si è visto sopra, di indiscutibili abilità politiche e militari come Maurizio di Nassau, avrebbe rappresentato un serio pericolo per l’indipendenza appena conquistata, dal momento che l’abitudine avrebbe trasformato l’ardore libertario in una riverente obbedienza a un sol uomo. Bentivoglio poneva, inoltre, l’accento su come la concordia interna fosse solo presunta, dal momento che troppo evidenti erano le sproporzioni tra le ricche province di Olanda e Zelanda e le altre. Da ultimo, un problema concreto per la stabilità della repubblica era rappresentato dal “difetto in materia di Religione”, ovvero dalla molteplicità delle confessioni (settarie, riformate, cattolica) professate nei Paesi Bassi. Con la cinica conclusione che «da tutte queste ragioni si può giudicare, che non sia per conservarsi nello stato presente questa nuova Republica, ma che più tosto sia per mancare in breve, e che finalmente sia per ridursi di nuovo sotto il governo d’un solo» (Bentivoglio, 1630).

Un monito che trova conferma nelle vicende dei decenni successivi, quando, la fine della Guerra dei Trent’anni, il fallimento della WIC e la crisi economica generarono un feroce dibattito sulla definizione della natura politica della repubblica, riassumibile in una domanda: quanto è necessaria in una repubblica una figura semi-monarchica come quella dello statolder? Da un lato il Partito degli Stati proponeva la sua abolizione, dall’altro il Partito orangista sottolineava la funzione unificante di un principe politico e militare. La morte di Guglielmo II nel 1650 e l’ascesa a gran pensionario d’Olanda nel 1653 di un autentico repubblicano come Johan de Witt, uno dei maggiori statisti della storia olandese, avrebbero portato nel 1654 alla firma dell’Atto di esclusione di Guglielmo III dai diritti ereditari. La sovranità e l’autonomia (eccetto in ambito militare e diplomatico) furono restituite agli Stati Provinciali e ai consigli comunali: si apriva così il periodo della «Vera Libertà», segnato da un clima di generale tolleranza religiosa, di conquiste filosofiche (un nome fra tutti: Baruch Spinoza) e matematiche e dalla strabiliante vittoria navale dell’ammiraglio Michiel de Ruyter sulla flotta inglese del 1667. La sconfitta di Carlo II fu l’occasione per la firma dell’Editto perpetuo, che abolì definitivamente lo statolderato. L’invasione francese del 1672 e la barbarica uccisione di Johan de Witt sancirono l’ascesa di Guglielmo III, il quale pose fine alla vera libertà repubblicana (Nadler, 2020).
Molte altre pagine si potrebbero scrivere a partire dagli spunti di riflessione offerti dal cardinale Bentivoglio. Da tempo la storiografia ha rigettato la funzione didascalica della storia e ampie trattazioni unicamente evenemenziali. Ciononostante, il confronto con le opere di Guido Bentivoglio, attento osservatore delle maschere, dei negotii e del proprio presente, può rappresentare un’utile palestra intellettuale per lo storico e il cittadino di oggi, chiamato a leggere, interpretare, ma soprattutto a vivere, in un mondo sempre più multipolare, come gli attualissimi avvenimenti continuano a dimostrare anche in seno al nostro stesso continente.

Marco Giuseppe Longoni
Marco Giuseppe Longoni è laureato in Scienze Storiche presso l’Università degli Studi di Milano. Specializzato in Storia Moderna, i suoi interessi di ricerca includono l’età della Riforma e della Controriforma, il Ducato di Milano spagnolo, la nobiltà italiana, la Storia militare e la cultura barocca.
Bibliografia
Baldinucci F., Notizie de’ professori del disegno da Cimabue in qua, Nella Stamperia di S.A.R. Per li Tartini, e Franchi, In Firenze, 1728; Bellori G. P., Le vite de’ pittori, scultori et architetti moderni etc., Parte prima, Per il Success. al Mascardi, In Roma, 1672; Belvederi R., Guido Bentivoglio e la politica europea del suo tempo (1607-1621), Liviana Editrice, Padova, 1962; Bentivoglio G., Relationi del cardinale Bentivoglio, voll. I-II, Da Erycio Puteano, In Anversa, 1630; Bentivoglio G., Della guerra di Fiandra, I-III, In Colonia, 1633-1639; Bentivoglio G., Memorie del cardinale Bentivoglio. Con le quali descrive la sua Vita etc., Per Giunti, e Baba, In Venetia, 1648; Bentivoglio G., Historia della guerra di Fiandra, Parte Prima, Appresso Gio. Battista Indrich, In Venetia, 1678; Bentivoglio G., Raccolta di lettere scritte del cardinal Bentivoglio in tempo delle sue Nuntiature di Fiandra, e di Francia, Appresso Stefano Loison, nella gran Sala del Palazzo, vicino alle Consultationi sotto l’insegna del nome di Giesù, In Parigi, 1680; Clerici A., Ragion di Stato e politica internazionale. Guido Bentivoglio e altri interpreti italiani della Tregua dei Dodici Anni (1609), «Dimensioni e problemi della ricerca storica», n. 2, 2009, pagg. 65-101; Croce B. (cur. Galasso G.), Storia dell’età barocca in Italia. Pensiero, poesia e letteratura, vita morale, Adelphi, Milano, 1993; De Stefani L. (cur.), La nunziatura di Francia del cardinale Guido Bentivoglio: lettere a Scipione Borghese cardinal nipote e segretario di stato di Paolo V, Le Monnier, Firenze, 1863-1870; Frescobaldi G., Il primo libro de’ madrigali a cinque voci, Appresso Pietro Phalesio, In Anversa, 1608; Garin E., L’educazione in Europa 1400/1600, Laterza, Roma-Bari, 1976; Guarini B. (cur. Piacente L.), La Didattica del Greco e del Latino. De ordine docendi ac studendi e altri scritti, Edipuglia, Bari, 2002; Guicciardini F., Storia d’Italia, Voll. I-III, Garzanti, Milano, 2006; Haskell F. (cur. Montanari T.), Mecenati e pittori. L’arte e la società italiana nell’epoca barocca, Einaudi, Torino, 2020; Le Roy Ladurie E., L’Ancien Régime. Il trionfo dell’assolutismo: da Luigi XIII a Luigi XIV (1610-1715), vol. I, Il Mulino, Bologna, 2000; Machiavelli N. (cur. Ruggiero R.), Il principe, Bur, Milano, 2008; Marino G. B. (cur. Russo E.), Adone, Bur, Milano, 2018; Mascardi A., La congiura del Conte Giovanni Luigi de’ Fieschi, Per Giacomo Monti, e Carlo Zenero, In Bologna, 1639; Merola A., Bentivoglio, Giulio in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. VIII, 1966; Nadler S., Spinoza e l’Olanda del Seicento, Einaudi, Torino, 2020; Suppa S. (cur.), Tacito e tacitismi in Italia da Machiavelli a Vico, Atti del convegno (Napoli, 18-19 dicembre 2001), Archivio della Ragion di Stato, Napoli, 2003; Tabacchi S., Maria de’ Medici, Salerno, Roma, 2012; Tacito (introd. Lenaz L., trad. Dessì F.), Storie, Bur, Milano, 2009; Livio, Storia di Roma dalla sua fondazione, Vol. quinto (libri XXI-XXIII), Bur, Milano, 1991.
Immagine di copertina: Il cigno minacciato, di J. Asselijn, 1650 circa. Rijksmuseum, Amsterdam (fonte: Wikipedia, licenza CC0)
Scarica l’articolo in formato PDF: