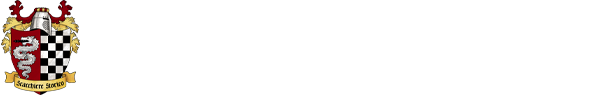di Michele Gatto
Secondo quanto afferma Cassio Dione, successivamente alla morte di Marco Aurelio per Roma sarebbe cominciata una nuova fase, con il passaggio «da un impero d’oro ad uno di ferro e ruggine»: in effetti, una volta conclusa l’esperienza della dinastia Antonina a seguito dell’uccisione di Commodo nel 192 d.C., ebbe inizio un periodo di grave crisi e di guerre civili, durante il quale l’elemento militare divenne sempre più preponderante. La situazione si normalizzò con l’ascesa al potere di Settimio Severo, acclamato imperatore dalle legioni della Pannonia nel 193 e in grado di sconfiggere gli altri pretendenti alla porpora, raggiungendo il potere assoluto nel 197 d.C.: di origine africana, Severo diede vita ad una nuova dinastia, legittimata attraverso la creazione di un legame con gli Antonini e nella quale ebbe un ruolo fondamentale la moglie, Giulia Domna.
Nata ad Emesa, in Siria, Giulia era figlia di Giulio Bassiano, un sacerdote del dio Sole, e sposò il futuro imperatore probabilmente nel 187 d.C.: secondo una tradizione, Severo l’avrebbe scelta proprio perché alcuni presagi la indicavano come futura moglie di un sovrano. Una volta insieme, questi cercarono di simboleggiare la rinnovata stabilità dell’impero, basata su un principio di successione dinastica che ben si ricollegava all’ultima fase dell’età antonina: emblematico è un episodio riportato da Cassio Dione, nel quale a Settimio Severo sarebbe apparsa in sogno Faustina Minore (moglie di Marco Aurelio) nell’atto di preparare il letto nuziale appena prima del matrimonio con la seconda moglie. Giulia Domna svolse sempre un ruolo di primo piano accanto al marito, esercitando una certa influenza e ricevendo perciò numerosi attributi onorifici: ad esempio, la vicinanza all’imperatore durante le campagne militari le valse il titolo di mater castrorum, mentre dopo l’elevazione dei figli Caracalla e Geta rispettivamente al rango di Augusto e Cesare, venne denominata mater Augusti et Caesaris; inoltre, fu la prima augusta a presenziare alla cerimonia dei Ludi saeculares, nel 204 d.C. La stessa svolta di Severo, a partire dal 195 d.C., verso un maggior autoritarismo, potrebbe essere stata indotta proprio dalla moglie, la cui origine orientale ben si sposava con una simile concezione del potere.

Giulia Domna si dimostrò quindi particolarmente abile dal punto di vista politico e attiva nel campo culturale: infatti, quando temporaneamente la sua influenza diminuì in favore del prefetto del pretorio Plauziano, ella avrebbe dato vita ad un circolo di intellettuali, tra l’altro dagli intenti educativi nei confronti dei figli e delle nipoti, sui cui partecipanti gli storici hanno dibattuto nel corso del tempo ma che annoverava probabilmente personaggi come Filostrato e Ulpiano. Si tratta di un qualcosa assolutamente innovativo, in quanto la promozione del circolo arrivava da una figura femminile, in grado di ispirare anche la produzione di opere letterarie e interessata alle questioni religiose, come testimonia la restaurazione del tempio di Vesta voluta dall’augusta, o il suo svolgimento di ruoli sacerdotali in occasione di rituali dedicati a Giunone e Diana. Assimilata spesso a diverse divinità, Giulia Domna vide affermato il proprio prestigio attraverso una grande quantità di iscrizioni ed immagini ad essa dedicate sia in Oriente, sia in Occidente, in particolare nei ritratti scultorei e monetali, capaci di mostrarcene la figura e le sue caratteristiche peculiari.
Un esempio può giungerci dal Museo Archeologico di Venezia, grazie ad una moneta bronzea coniata a Smirne, nella provincia d’Asia (BMC Greek XVI, n. 389): al rovescio, vi è raffigurata la dea Roma elmata e seduta, reggente con la destra un tempio tetrastilo, mentre nella sinistra ha una lancia; la legenda è ΠΡΩ ΑCIAC Γ ΝΕΩΚΟΡΩΝ CΜΥΡ. Infatti, in occasione del viaggio in Oriente compiuto tra il 214 e il 215 d.C. da Giulia e dal figlio Caracalla (nel frattempo divenuto imperatore), la città avrebbe ottenuto per la terza volta una neokoria, cioè il titolo di “guardiana del tempio”, in genere concesso per la costruzione di edifici sacri dedicati al culto imperiale; tuttavia, la presenza della dea Roma potrebbe indicare come un tempio precedentemente ad essa dedicato fosse stato indirizzato ora anche al culto dell’imperatore. Ma in realtà è sul diritto che dobbiamo soffermarci, vista la presenza del ritratto di Giulia Domna insieme alla legenda IOY ΔOMNA CEBACTH: dal volto dell’augusta, il cui busto drappeggiato è volto a destra, emerge soprattutto la sua pettinatura caratterizzata dall’ondulazione dei capelli sui lati, a coprire le orecchie, per poi ricongiungersi in una voluminosa crocchia intrecciata occupante buona parte del retro del capo. Questo genere di acconciature si ricollega alla moda delle augustae antonine, che al volgere del III secolo d.C. subì nuove accentuate variazioni, sebbene sia necessario evidenziare un aspetto fondamentale: si trattava in realtà di parrucche. Il loro utilizzo era largamente diffuso, ma in questa fase conobbe una vera e propria esplosione, come riporta anche Tertulliano, tanto da essere addirittura riprodotte separatamente e applicate sui ritratti scultorei evidenziando le differenze cromatiche e morfologiche rispetto ai capelli autentici, che potevano affiorare in minima parte al di sotto di esse. La tipologia di questo ritratto di Giulia Domna, nonostante la datazione, sembra corrispondere maggiormente a quella di età più giovanile rispetto alla seconda a lei dedicata: inaugurata sull’arco di Leptis Magna, vedeva sempre una calotta con spartitura centrale ma più allungata sui lati, dotata di trecce che partendo dalle tempie incorniciavano il volto, ed una crocchia posteriore a cerchi concentrici, primo segnale di un’evoluzione visibile anche tra le altre donne severiane. Infine, la bellezza dei lineamenti del ritratto monetale di Giulia pare confermare quanto riportato dall’Historia Augusta, sebbene questa stessa fonte sostenga di un’improbabile matrimonio incestuoso tra lei e il figlio Caracalla.

Morto Settimio Severo nel 211 d.C., l’impero avrebbe dovuto infatti essere diviso tra i suoi due figli, Caracalla e Geta, ma l’anno seguente l’inimicizia tra i due portò al fratricidio del secondo da parte del primo e, secondo Cassio Dione, Geta sarebbe morto proprio tra le braccia di Giulia Domna. Questa, che a quanto riporta Erodiano oltre al crimine fu costretta ad assecondare la versione ufficiale del complotto e la damnatio memoriae di Geta, anche durante il regno del figlio conservò una posizione di rilievo, ricevendo l’appellativo di mater Senatus et patriae: non a caso, proprio in questa fase Caracalla emanò l’editto che concedeva la cittadinanza a tutti gli abitanti dell’impero, forse risultato dell’influsso della madre. Ad essa l’imperatore delegò diversi compiti amministrativi, viste le numerose campagne militari in Oriente che finirono però per provocarne la fine. Nel 217 d.C., durante una spedizione contro i Parti, Caracalla venne fatto uccidere dal prefetto del pretorio Macrino che ne usurpò il trono: tuttavia, temendo il prestigio di Giulia e il suo stretto legame con l’esercito, il nuovo imperatore decise di escluderla dai vertici dello Stato e di esiliarla ad Antiochia. L’augusta, già debilitata da una ferita che si era procurata alla notizia della morte del figlio, decise allora di lasciarsi morire e, dopo essere stata inizialmente sepolta nel mausoleo di Augusto, Elagabalo l’avrebbe in seguito divinizzata traslandone le ceneri nel mausoleo di Adriano.
Ad ogni modo, Giulia Domna aveva ben esercitato il proprio ruolo di matrona e imperatrice, diventando così un punto di riferimento per le sue succeditrici del ramo siriaco e femminile della dinastia dei Severi.

Michele Gatto – Scacchiere Storico
Michele Gatto è uno studioso dell’antichità greca e romana, in particolare della Grecia in età classica e di Roma in età imperiale. È specializzato in Numismatica Antica. I suoi interessi arrivano a comprendere inoltre la storia bizantina.
Bibliografia
Bertolazzi R. 2017, Julia Domna: public image and private influence of a syrian queen, Calgary.
BMC Greek XVI = R.S. Poole, A catalogue of the Greek coins in the British Museum. Ionia, Bologna (rist.) 1964.
Boatwright M.T. 2021, Imperial women of Rome: power, gender, context, Oxford.
Buccino L. 2011, “Morbidi capelli e acconciature sempre diverse”. Linee evolutive delle pettinature femminili nei ritratti scultorei dal secondo triumvirato all’età costantiniana, in E. La Rocca, C. Parisi Presicce, A. Lo Monaco (a cura di), Ritratti. Le tante facce del potere (catalogo della mostra, Roma, Musei Capitolini, 10 marzo – 25 settembre 2011), Roma 2011, pp. 360-383.
Burrell B. 2004, Neokoroi: greek cities and roman emperors, Leiden/Boston.
Calza R. 1960, s.v. Giulia Domna, in Enciclopedia dell’Arte Antica, Roma, pp. 922-924.
Fernandes E. 2015, Le emissioni di Giulia Domna: strumento per radicare una dinastia e di esaltazione dell’augusta, in “Secondo Bollettino Circolo Numismatico Partenopeo” 2, pp. 37-54.
Marzo L. 2019, Mater et Augusta: la “maternità istituzionale” di Giulia Domna tra evidenze storiche e finzioni letterarie, in “Classica et Christiana. Periodico del Centro di Studi Classici e Cristiani” 14, pp. 165-185.
Viarengo G. 2007, Il circolo di Giulia Domna tra proiezioni e realtà storica, in “Materiali per una storia della cultura giuridica” 1, XXXVII, pp. 191-201.
Immagine di copertina: Ritratti dalla Sala X del Museo Archeologico di Venezia (fonte: autore, Mentnafunangann; licenza, CC BY-SA 4.0)